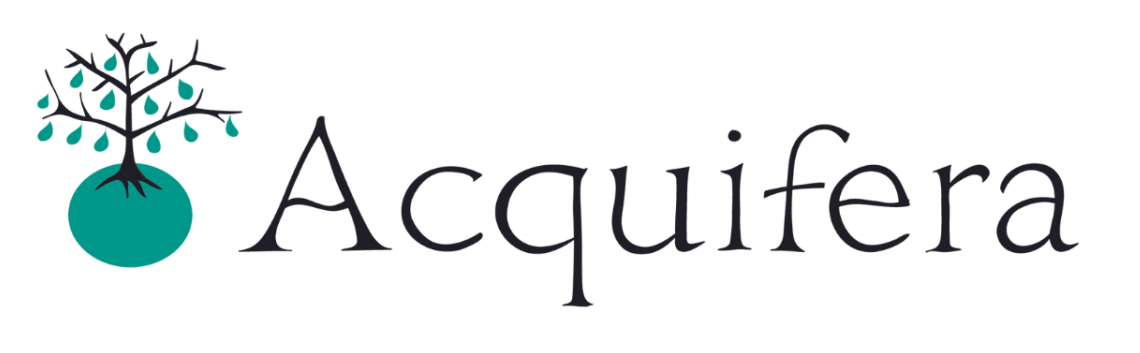28 luglio 2010: A New York, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che riconosce l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari tra i diritti umani fondamentali. La storica risoluzione, su mozione presentata da Evo Morales Ayma, Presidente della Bolivia, e da una trentina di altri paesi, sancisce che “l’acqua potabile e i servizi igienico-sanitari sono un diritto umano essenziale per il pieno godimento del diritto alla vita e di tutti gli altri diritti umani”.
Nello stesso anno cominciavo a partecipare a progetti di cooperazione focalizzati alla gestione comunitaria dell’acqua in America Latina e di lì a poco avrei cominciato a promuovere l’approccio tecnico-sociale o tecnico-comunitario nei temi del diritto all’acqua, fino ad arrivare proprio là dove tutto era cominciato: in Bolivia.
Non riuscendo a percepirle come due metodologie sconnesse tra loro uso spesso il termine tecnico-sociale. A dirla tutta, le migliori esperienze in cui mi è capitato di imbattermi, in Tanzania, Senegal, Nicaragua e Bolivia, erano proprio quelle in cui pur senza perdere di vista il focus centrale del problema – ovvero che la difficoltà di accesso pubblico all’acqua porta alla mancanza di salute, di lavoro e quindi di libertà e opportunità – era possibile portare avanti parallelamente le due metodologie che fino a pochi anni fa erano considerate antitetiche: quella tecnica, in cui un’organizzazione mette a disposizione le proprie risorse (umane ed economiche) per analizzare il contesto e migliorare le infrastrutture che permettano un miglior accesso all’acqua, e quelle sociale-comunitaria, dove si cerca politicamente, mutualmente e strutturalmente di permettere che il processo di cambio sia avviato e condotto proprio da chi ne ha l’esigenza e/o l’urgenza.
Nel primo caso il cambiamento è sicuramente più rapido e quantificabile, ma può avere il difetto di svilupparsi su piccola scala e spesso non rappresenta un’alternativa sostenibile, in cui un cambio nella forma a breve termine produce un cambio nella sostanza a lungo termine, degenerando quindi in piccoli progetti fini a se stessi, che vanno prorogati ogni anno all’infinito e che se non gestiti dalle comunità locali possono dissolversi in pochi anni, lasciando un gran senso di frustrazione e tanto cemento nel deserto.
Nel secondo caso c’è da una parte il vantaggio di poter arrivare direttamente al cuore del problema, risvegliando le coscienze e trasmettendo il senso di diritto inalienabile di ogni essere umano di poter accedere all’acqua per uso umano e per uso agricolo, ma dall’altra mi è capitato di osservare che anche un certo tipo di programma formativo e di programma socio-educativo su questo tema scadeva rapidamente nella teoria e che senza un linguaggio e degli strumenti adatti faceva la fine dei famosi pozzi alimentati a pannelli solari: una grande idea ma al primo guasto la risorsa era perduta.
Detto questo ho letto e visitato molti progetti sull’accesso all’acqua e mi sono concentrato su quelli più efficaci, dove infatti venivano premiate entrambe le metodologie, ricavandone tre concetti chiave:
– la gestione dell’acqua deve essere in mano il più possibile ai territori, i quali possono rapidamente apprendere a sviluppare programmi di miglioramento dell’accesso idrico se gliene vengono date le possibilità, l’agibilità e il tempo, mediante educazione, sensibilizzazione, coinvolgimento istituzionale e formazione teorico-pratica.
– Il contributo della cooperazione tecnica è fondamentale laddove si riesca a migliorare e dettagliare le informazioni riguardo alla risorsa idrica, siano esse di tipo idrogeologico, ingegneristico, fisico e biochimico. Affinché un approccio del genere sia davvero utile alla popolazione locale c’è bisogno di un lavoro di equipe e i lavorare “fianco a fianco”, in modo che le informazioni circolino e siano usufruibili, anziché diventare documenti utili unicamente all’autoalimentazione progettuale dei vari attori della cooperazione.
– I mezzi da utilizzare devono essere facilmente reperibili localmente e affini alla cultura del luogo, cercando sempre un compromesso tra sapere scientifico e saperi tradizionali.
La giusta sintesi di questi concetti si evince dalla stessa Costituzione della Bolivia, che recita che è fondamentale “fornire alle popolazioni indigene quegli strumenti con i quali esse diventino protagoniste del loro stesso processo di cambio”, e da molte esperienze positive di riappropriazione comunitaria e territoriale, come quella emblematica e importante di Cochabamba, dove nel 2000, a seguito della privatizzazione dell’acqua a favore della multinazionale Bechtel e del conseguente aumento del 50% dei prezzi in bolletta, la popolazione rurale e quella urbana esplosero in una violenta e disperata protesta, bloccando per settimane la città e costringendo il governo boliviano a fare passi indietro.
Da quel momento in Bolivia la popolazione si rese conto di quanto l’accesso a questa vitale risorsa non fosse così scontato e ha cominciato ad organizzarsi, con il risultato che il Municipio di Cochabamba è il territorio più attivo nell’organizzazione e gestione comunitaria dell’acqua, attraverso ripetuti programmi educativi a partire dalle scuole materne, soprattutto nelle piccole e inaccessibili comunità montane. A Cochabamba per esempio molti sono a conoscenza del fatto che da 8 anni l’accesso all’acqua potabile è entrato a far parte ufficialmente della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e ai bambini delle elementari viene spiegato che sul pianeta una persona su otto non ha ancora accesso all’acqua potabile. Che oltre 443 milioni di giorni di scuola vengono persi a causa di malattie legate alla qualità dell’acqua e alla mancanza di strutture igieniche. Che le promesse dell’ Assemblea Generale dell’ONU di impegnarsi a dimezzare, entro il 2015, il numero di persone sulla terra che non ha accesso all’acqua potabile, erano destinate a non essere mantenute, perché la custodia di risorse come l’acqua e la terra non può essere vincolata alle logiche di mercato e non deve essere delegata ad altri.
Al contrario, deve diventare l’impegno di tutti.
Sulla base di questi concetti chiave si sono sviluppati programmi multidisciplinari che a partire dal lavoro congiunto e dal partenariato tra organizzazioni di geologi, ingegneri, educatori, antropologi, architetti e medici sono riusciti ad agire a tutto tondo su vaste aree vulnerabili, in Africa, America Latina e Oriente, come quelli di gestione transfrontierizia delle fonti d’acqua al confine tra Guatemala, Salvador e Honduras, o quelli che hanno portato alla nascita della Scuola di Salute indigena Tekove Katu nel Chaco boliviano, dove ogni anno 200 giovani studenti indigeni provenienti dalle comunità rurali dell’Oriente Boliviano vengono formati, istruiti e abilitati nei temi della salute del corpo, dell’ambiente e della cultura, accostando alle pratiche di calcolo della portata di una sorgente la teoria sulle buone pratiche di difesa della risorsa idrica dallo contaminazione antropica, dallo sfruttamento e dall’estrattivismo più insulso.
Esempi virtuosi nati da una visione organica, anziché riduttivista, che pone il problema al centro e che si focalizza su una soluzione poliedrica, che dia dignità alle sue diverse declinazioni.
Acqua, terra, alimentazione, casa, salute, opportunità, libertà. Diritti umani universali che in quanto tali vanno affrontati anche politicamente, creando i presupposti e il terreno fertile su cui organizzare gli adattamenti strutturali che permettano di unire le buone pratiche, di infittire la rete di chi difende questi diritti e di poter agire su vasta scala, lungimirantemente. Alla frase “quello che facciamo è solo una goccia nell’Oceano”, Madre Teresa di Calcutta aggiungeva “ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Un vecchio detto indigeno puntualizza “ma una goccia dell’oceano, se presa da sola, può evaporare, l’intero Oceano no”.
Niccolò Giordano